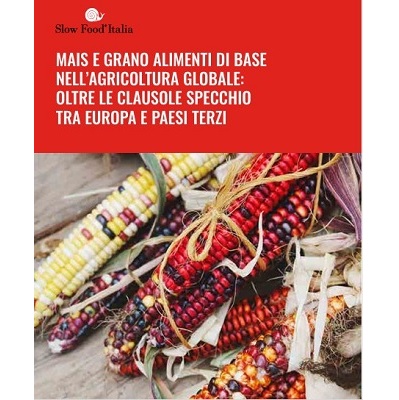
| Partiamo dai dati. Per quanto riguarda il mais, l’Ue ne importa ogni anno circa 15 milioni di tonnellate, prevalentemente da Ucraina e Brasile, ma anche da Argentina e Stati Uniti; per quanto riguarda il grano tenero, in stagioni normali ne importa circa 8 milioni di tonnellate, principalmente da Stati Uniti, Canada, Australia, Ucraina e Russia; per quanto riguarda il grano duro, nel 2024 le importazioni all’interno dell’Ue sono ammontate a poco più di 1,7 milioni di tonnellate. Slow Food chiede che ai prodotti importati nell’Ue vengano applicate le stesse norme in vigore per le produzioni comunitarie. Oggi questo non succede e fuori dai confini dell’Unione si possono utilizzare sostanze che i regolamenti comunitari vietano. Paradossalmente, spesso si tratta di composti che provengono dai Paesi europei (dove però non possono venire utilizzati) ed esportati all’estero per essere usati su colture (tra cui i cereali) che poi vengono esportate proprio nell’Ue. Poco rassicura sapere che i cereali d’importazione rispettino i cosiddetti LMR, i limiti massimi di residui per i pesticidi nelle colture alimentari e foraggere: nella cerealicoltura, infatti, la tipologia di sostanza più utilizzata è quella dei diserbanti, che vengono impiegati prevalentemente in “pre-emergenza”, ovvero subito prima o contemporaneamente alla semina. Siccome questi trattamenti avvengono lontano dalla raccolta, è piuttosto improbabile che nel raccolto si trovino residui significativi. A parte i residui, però, il tema relativo all’utilizzo di sostanze chimiche riguarda gli effetti dannosi sull’ambiente: di certo, infatti, le sostanze chimiche si depositano sul suolo, contaminando le acque e aggredendo i microrganismi della fertilità, e inquinano l’aria. I danni, insomma, riguardano la sanità dei suoli, delle acque interne e dei mari, la biodiversità, la salute degli operatori che le utilizzano, la salute delle comunità che vivono in prossimità delle grandi monocolture. Gli obiettivi da centrare, dunque, sono molteplici: non solo tutelare i consumatori europei dall’esposizione a prodotti meno salubri e proteggere i produttori interni da forme di concorrenza sleale dovuta a costi inferiori in altre aree del mondo, ma anche e soprattutto per difendere il diritto alla salute delle comunità locali dei paesi terzi dallo strapotere dei colossi dell’agroindustria, disposti a sacrificare il benessere di persone e ambiente sull’altare del proprio profitto. |


